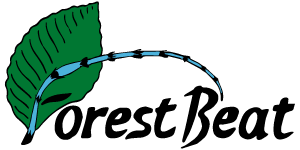All’interno di una faggeta la prima cosa che attira la nostra attenzione è ovviamente la sua componente arborea: le chiome degli alberi che si intrecciano tra loro, i rami decorati da migliaia di foglie, i tronchi imponenti dalla corteccia ricoperta di muschi e licheni. Ammiriamo i giochi di luce che si creano tra il fogliame, i colori e le atmosfere stagionali, le voci ed i suoni di chi abita la foresta. C’è così tanto da scoprire attorno e sopra di noi, che spesso si finisce per ignorare che la parte più importante di questo ecosistema si trova invece sotto i nostri piedi. Ai piedi dei faggi secolari e all’ombra delle loro fronde, nel corso dei millenni un suolo ricco e abbondante si è andato accumulando sopra lo strato calcareo della roccia madre. Questo mondo buio, umido e profumato, protetto dal letto di foglie morte e trattenuto dalle radici delle piante, è il vero e proprio “organismo”, mentre noi, gli animali e gli alberi attorno non siamo altro che piccole protuberanze sparse sulla sua pelle.

La parte più importante dell’ecosistema forestale si trova sotto i nostri piedi
Il suolo di una foresta vetusta racchiude la stragrande maggioranza della biodiversità di quest’ultima; si dice che in un cucchiaino di terreno in buona salute si possa trovare un numero di organismi persino superiore ai sette miliardi di umani sulla Terra! Nello specifico si tratta soprattutto di specie talmente piccole da risultare invisibili all’occhio umano, la cui presenza viene però rivelata da tanti segni. L’odore forte di muffa della decomposizione e l’aroma dei funghi, ad esempio, sono alcune delle sensazioni che ci permettono di “vedere” parte di questi attori microscopici all’opera nella lettiera.
Nel suolo, infatti, si svolgono i fondamentali processi di decomposizione e riciclo della materia organica; qui vengono messi a disposizione delle piante gli elementi chimici e sintetizzate le sostanze nutritive necessarie alla vita ed allo sviluppo di tutte le specie che vivono sulla sua superficie. Gli enzimi di batteri, attinomiceti e funghi demoliscono chimicamente la materia organica in decomposizione e ne rielaborano le molecole creando l’humus, il componente chimico più importante e caratteristico del suolo.
“L’ecosistema lettiera” ospita quindi intere schiere di abili architetti, ingegneri, chimici e artigiani che distruggono, scavano, elaborano, modificano i materiali di scarto provenienti dal mondo superficiale e la struttura del terreno stesso. Questi a loro volta se la devono vedere costantemente con tutta una serie di temibili predatori e parassiti. Nonostante la scala ridotta, si tratta di un mondo assai complesso ed antico (i microbi del suolo vivono sulla Terra da oltre un miliardo di anni!), zeppo di storie e drammi avvincenti di cui però sappiamo ancora troppo poco.
La lettiera ospita gran parte della biodiversità della faggeta; in essa si svolge gran parte dei processi di decomposizione e rielaborazione della materia organica che proviene dal mondo superficiale.
La prima storia che vogliamo raccontarvi è quasi una storia d’amore, quella di un’antichissima simbiosi in atto tra le piante e i funghi del sottosuolo. Il micelio di numerose specie di funghi, attraverso dei lunghi filamenti, le ife, entra in contatto intimo con le parti più sottili degli apparati radicali delle piante superiori, formando un apparato che si definisce micorriza. In cambio di azoto, fosfati e acqua, i funghi ricevono infatti le sostanze nutritive sintetizzate dalle piante e che si accumulano sulla superficie delle radici, nella cosidetta rizosfera. Questa relazione mutualistica, ovvero di scambio reciproco, è la forma di simbiosi più diffusa sul nostro Pianeta, dove esiste in quasi tutti gli ambienti naturali da oltre 450 milioni di anni. Ma gli scambi tra pianta e fungo possono essere anche di altra natura e molto più intricati. Le micorrize di fatto sono considerate anche come degli snodi di comunicazione tra individui e specie di piante diversi.

La micorriza è un’antichissima forma di simbiosi tra un fungo ed una pianta superiore. Entrando in contatto rispettivamente attraverso micelio e apparato radicale, i due organismi si scambiano minerali, acqua e sostanze nutritive.
Corallorhiza trifida è una piccola orchidea selvatica tipica delle nostre foreste. All’inizio dell’estate, i suoi steli dritti di colore giallo-verdastro e alti pochi centimetri emergono dalla lettiera per sostenere dei minuscoli fiori bianchi macchiati di fucsia. L’aspetto poco appariscente di questa piantina però non deve ingannare: la sua biologia infatti è davvero sorprendente. Quest’orchidea non produce clorofilla e non è in grado di effettuare la fotosintesi, ma è un parassita che vive alle spese dei funghi delle succitate micorrize, da cui essa sottrae le sostanze nutritive attraverso le sue radici, più precisamente rizomi, dalla forma vagamente simile a quella del corallo (il nome “corallorhiza” significa appunto “radice a corallo”).
Dettaglio di Corallorhiza trifida, piccola orchidea parassita delle nostre foreste.
In questi giorni d’inverno sul manto di neve alla base dei faggi più grandi, si possono notare tanti puntini neri, come semi di papavero in movimento. Si tratta di collemboli, minuscoli invertebrati della lettiera, che emergono a migliaia sulla superficie della neve per nutrirsi dei pollini, delle spore e degli altri residui organici che vi si sono accumulati. Il nome inglese di questi animali, “springtails” (“code a molla”), viene dalla furca, un’appendice addominale elastica, che funziona come una molla e permette loro di compiere salti pari a 100 volte la loro lunghezza. La maggioranza di questi acrobati della foresta vive però nel terreno: quasi degli erbivori in miniatura, questi animali pascolano su funghi e microbi della rizosfera, controllandone il numero e la distribuzione, e fertilizzano a loro volta il suolo con i propri escrementi.
Alcuni collemboli saltano sulla neve alla base di un faggio per nutrirsi della materia organica depositata sulla sua superficie.
Soffermandoci ancora ad osservare con attenzione la lettiera di una faggeta matura, con un po’ di fortuna il nostro sguardo potrebbe individuare un pallino rosso in movimento. Pochi millimetri di velluto rosso brillante, otto zampe raccolte in gruppi di due e uno sviluppato apparato boccale che tradiscono una parentela con i ragni e identificano un acaro trombidiide. Il colore vivace di questo piccolo abitante del suolo informa i potenziali predatori del suo sapore poco appetibile. Predatore a sua volta di collemboli e altri minuscoli invertebrati, che, come abbiamo appena visto, si nutrono di funghi e batteri, questo animaletto color rubino ne tiene sotto controllo le popolazioni e quindi contribuisce al mantenimento degli equilibri dinamici di questo ambiente.

Un piccolo acaro del genere Trombidium, coloratissimo abitante delle faggete mature ed instancabile predatore di collemboli e piccoli invertebrati del suolo
Il nostro sguardo può cogliere un altro piccolo invertebrato alla costante perlustrazione del suolo. Sette paia di zampe e due lunghe antenne nascoste da una spessa corazza: il porcellino di terra (Porcellio sp.) non è un insetto né un millepiedi, bensì un piccolo crostaceo dall’aspetto preistorico che ha abbandonato l’ambiente acquatico per vivere sulla terraferma. È rimasto comunque legato agli ambienti umidi, poiché preferisce muoversi sotto le pietre, le foglie ed il legno morti, dove si ciba di materiale vegetale di scarto, appunto, provvedendone alla frammentazione e decomposizione.
Il porcellino di terra non è né un insetto né un millepiedi, ma un crostaceo che ha abbandonato la vita acquatica per quella sulla terraferma.
Striscia ed è viscido, sordo e praticamente cieco, eppure l’avversione che molti di noi provano per il lombrico (Lumbricus sp.) è del tutto ingiustificata. Questo infatti è in assoluto l’animale più importante (e abbondante) delle nostre foreste. Grazie alle minuscole setole sparse sul suo corpo e ad un movimento a fisarmonica, il lombrico riesce a fare presa tra le particelle del terreno, scavandovi profonde gallerie al suo interno (si parla di oltre 500 metri di tunnel sotto 1 metro quadro di lettiera!) Queste gallerie permettono l’infiltrazione della pioggia e dell’ossigeno e consentono alle radici delle piante, ai funghi e ai batteri di svilupparsi. Gli anellidi (la famiglia a cui appartiene il lombrico) si nutrono di materia in decomposizione, di resti di piccoli organismi e di argilla. Tutto questo materiale viene magicamente trasformato nel loro intestino in escrementi ricchi di azoto, fosforo e potassio che fertilizzano il suolo. Senza questi artigiani del suolo non esisterebbe la “terra” come la conosciamo, tantomeno la stupefacente ricchezza di vita sulla sua superficie!
Il lombrico è forse la singola specie più comune ed importante delle nostre foreste. Si nutre di materiale organico di scarto e lo trasforma in escrementi ricchi di elementi che fertilizzano il suolo.
Il lombrico è anche sul menu di molte specie forestali, che se ne nutrono soprattutto durante le giornate umide e di pioggia, quando questi si muove allo scoperto. Tra i suoi predatori troviamo quindi anfibi come il Rospo comune (Bufo bufo) e la Salamandra pezzata appenninica (Salamandra salamandra gigliolii), endemica dell’Appennino, ma anche dei veri specialisti come la Tordela (Turdus viscivorus), uccello passeriforme della famiglia dei Turdidi, e il Riccio (Erinaceus europaeus).
La coloratissima Salamandra pezzata appenninica si muove lentamente nella lettiera a caccia di lombrichi, lumache ed altri invertebrati.
Siamo abituati a doverlo schivare quando attraversa la strada davanti ai fari dell’automobile oppure a scoprirlo quale ospite dei nostri giardini, ma il riccio è infatti anche un abitante delle faggete montane. Di abitudini notturne e crepuscolari, questo insettivoro pattuglia la lettiera della foresta alla ricerca di lombrichi, appunto, di lumache ed altri invertebrati. Con l’arrivo dei primi freddi, poi, il riccio cerca un rifugio sicuro nel cavo di un tronco o sottoterra, dove trascorrere l’inverno immerso in un profondo letargo.

Il riccio (Erinaceus europaeus) è un insettivoro di abitudini prettamente notturno ed un grande predatore di invertebrati della lettiera forestale.
Tra i vertebrati delle faggete appenniniche, l’arvicola rossastra è però sicuramente il più comune ed abbondante. Questo piccolo roditore si nutre prevalentemente di erbe, radici, semi e bacche e le sue popolazioni possono subire delle vere e proprie esplosioni numeriche in seguito alle annate di “pasciona”, ovvero di fruttificazione dei faggi. Poiché sono alla base della dieta di molti carnivori forestali, le arvicole si guardano bene dall’uscire allo scoperto se non per brevi momenti. Preferiscono piuttosto muoversi sotto la lettiera o, in inverno, sotto la coltre nevosa, dove scavano lunghe e complesse gallerie. In questo mondo sotterraneo le arvicole mettono al mondo la loro prole e immagazzinano il cibo in vere e proprie dispense. A volte, alcune di queste riserve restano inutilizzate e i semi in esse raccolti finiscono quindi per germinare. In questo modo le arvicole contribuiscono alla dispersione delle specie vegetali e, attraverso i loro tunnel, anche ad aerare e smuovere il suolo.

Un’arvicola rossastra (Myodes glareolus) fa capolino da una galleria scavata nel terreno alla base di un faggio secolare.
Nella dieta delle arvicole rientrano frequentemente parti sotterranee di specie vegetali note ai botanici con il nome di geofite. Si tratta di piante perenni erbacee che, durante la stagione fredda, non presentano organi aerei, quali steli, foglie e fiori, e le cui gemme si trovano in organi sotterranei come bulbi, tuberi e rizomi. Queste piante mostrano un eccellente adattamento alla vita in climi freddi e caratterizzati da inverni nevosi. Non c’è da stupirsi, quindi, se gran parte delle specie vegetali che fioriscono al suolo nelle fredde faggete appenniniche rientra in questa categoria. Esse fioriscono soprattutto agli inizi della primavera e subito dopo lo scioglimento della neve. In questo modo primule, crochi, epatiche, colombine e scille (tanto per citare le specie più appariscenti e colorate) riescono ad approfittare della massima irradiazione solare disponibile al suolo prima che germoglino le foglie dei faggi e si chiuda la volta arborea.
I fiori gemelli della pianta geofita Scylla bifolia sono tra i più precoci della faggeta, poiché emergono dalla lettiera già alla fine dell’inverno.
La pedologia o studio del suolo è una disciplina fondamentale nell’ambito delle scienze naturali, poiché nel terreno è letteralmente depositata la memoria di un territorio: analizzandolo se ne apprende la storia e se ne stabilisce lo stato di salute. Da una sezione verticale del suolo i pedologi possono esaminare i vari strati, gli orizzonti come vengono definiti, che lo costituiscono. Si parte dal più profondo ed antico, di solito di colore chiaro e dalla composizione prettamente minerale, per arrivare sino al più superficiale, scuro e grossolano: il terreno ricco di materia organica in decomposizone che tutti conosciamo. Ad ogni strato, colorazione e struttura corrisponde una datazione, un’origine e una composizione chimica diverse. E dalle varie combinazioni di questi fattori dipende anche la produttività di un terreno. I ricchi e fertili suoli delle faggete dell’Appennino Centrale, ad esempio, hanno avuto origine dalle ceneri e dai lapilli espulsi durante le eruzioni degli antichi vulcani laziali, oramai inattivi. E ciò è testimoniato anche dall’abbondanza di silice che si ritrova tra le particelle di humus e argilla deposte sotto lo strato organico più superficiale. Come fare a scoprirlo? Semplice, basta mettere sotto i denti un pizzico di terra e i cristalli di silice si faranno sentire sotto i denti! Ce lo dimostra dal vivo il professor Luigi Hermanin della Facoltà di Scienze Forestali e Ambientali dell’Università di Firenze.
Il professor Luigi Hermanin, dell’Università di Firenze, ci mostra un metodo assai semplice e divertente per individuare la presenza di un suolo di origine vulcanica!
Sul nostro Pianeta il suolo si accumula assai lentamente. Si ritiene infatti che occorrano circa 10.000 anni per far sì che se ne depositi appena un centimetro. Questa sua lentissima formazione pertanto non è affatto in grado di stare al passo con l’eccessiva perdita a cui si assiste al giorno d’oggi, in tutto il Mondo come anche nel nostro Paese. Disboscamenti, prelievo indiscriminato, agricoltura intensiva, urbanizzazione selvaggia e inquinamento stanno avvelenando e facendo scomparire il suolo ad un ritmo frenetico. Ciò comporta anche instabilità geologica, minore disponibilità idrica e diminuzione della produzione. Non è mai superfluo ribadire l’importanza del suolo e della sua conservazione, poiché da esso dipende la vita di tutti gli abitanti della Terra. Nessuno di noi infatti è in grado di creare ex-novo il suolo o preservarlo bene come sanno fare gli alberi delle nostre foreste. È arrivato il momento di dimostrare loro tutta la nostra riconoscenza!

© Bruno D’Amicis / Umberto Esposito 2013-2016 – www.silva.pictures
Tutti i diritti di riproduzione anche parziale del testo e delle immagini sono riservati.
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere usata in qualsiasi forma senza il permesso scritto degli autori.